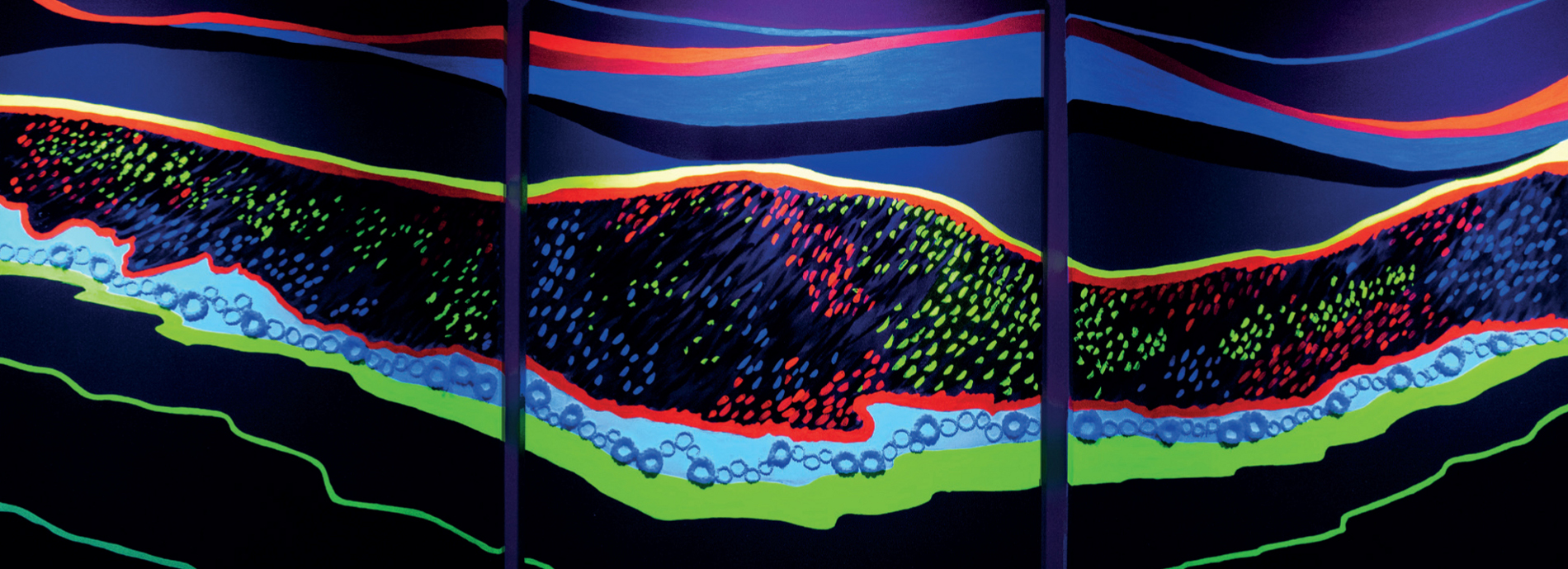
- Home
- Arte - Articoli Meno Recenti
- L’Abbazia dei Santi Mauro e Felice
A poche decine di metri dal tracciato dell’ex ferrovia Spoleto Norcia, a metà circa della valle percorsa dalle limpide e fresche acque del Nera e poco distante dall’antico castello, si erge il complesso abbaziale dei santi Felice e Mauro, costituito dalla Chiesa e dal Monastero che un sapiente restauro effettuato alcuni anni fa ha restituito all’antico splendore ed alla fruizione di tutti coloro che nel silenzio della natura possono ritrovarvi momenti di autentico relax fisico e spirituale. Amo particolarmente questa Chiesa, che attrasse la mia attenzione mezzo secolo fa, quando adolescente andavo a pescare (quasi sempre in maniera infruttuosa) nelle acque del fiume. A distanza di cinquant’anni torno spesso e volentieri in questo luogo magico per contemplare la sobria bellezza dell’armonica facciata, percorrere l’ombrosa navata, godere della vista dei pochi affreschi rimasti: un’ ingenua adorazione dei magi ed il severo Cristo benedicente del catino dell’abside. Mi piace salire i sette gradini che portano verso l’altare, immergermi nei profondi significati simbolici che sono disseminati lungo il percorso: il pavimento dell’altare dove sono incisi due “fiori della vita” a lato di un’incisione perfettamente circolare. Mi sorprendo ad osservare il fascio di luce che penetra dolcemente dal rosone. Mi piace scendere le scale , accarezzando (mi viene spontaneo farlo ogni volta) uno o l’altro pluteo cosmatesco con il classico disegno a quinconce. I quattro elementi costitutivi dell’universo ed il cerchio centrale: la quint’essenza che tutto pervade. Due strette scale (una per lato) portano alla suggestiva cripta dove un possente sarcofago in pietra rossa contiene le spoglie mortali dei Santi Felice, di suo padre San Mauro e della nutrice. Una grata di ferro protegge il sarcofago ad impedire fenomeni eccessivi di idolatria, da quando in epoche remote nel giorno commemorativo della morte dei due santi (il 16 giugno) tutte le mamme portavano i loro bambini per lavarli con le acque che scaturivano da una miracolosa sorgente. Li avrebbe preservati dalla scabbia. Uscendo, con gli occhi assuefatti alla penombra, i rilievi della facciata diventano accecanti e tutto acquista un nuovo significato. Qui la scultura romanica spoletina ha raggiunto uno dei suoi massimi vertici: dall’alto verso il basso la vista scivola dall’ Agnello mistico (il cui sguardo cadrebbe secondo un’antica leggenda dove si trova un tesoro) allo stupendo rosone con le sue 16 coppie di colonnine ( l’esatta somma del numero degli apostoli col numero degli evangelisti), iscritto in un quadrato ai cui angoli troviamo le raffigurazioni dei quattro evangelisti. Poco sotto, nell’altorilievo due scene raffiguranti i due santi nell’atto di uccidere il dragone e più a destra San Felice che “resuscita” il figlio di una vedova. Dietro la leggenda, che ha ispirato l’interessante rilievo, va ricercata la storia di questi devoti cristiani, che sfuggiti alle persecuzioni del III° - IV° secolo nella natia Siria, emigrarono insieme ad altre 300 persone stabilendosi in questa zona che provvidero a colonizzare ed evangelizzare dopo l’incuria e lo sbando seguito al dissolvimento dell’Impero Romano. Qui Mauro e Felice alternavano il lavoro alla preghiera e la loro fama di uomini devoti crebbe al punto che gli abitanti del luogo chiesero loro di liberarli dal pestifero dragone che ammorbava l’aria col suo alito facendo numerose vittime, specie tra i bambini. Cosa che Mauro e Felice riuscirono a fare con grande gioia della popolazione.
In realtà gli anonimi scultori della fascia tradussero in immagini di grande impatto emotivo la meritoria opera di ingegneria idraulica con la quale Mauro e suo figlio riuscirono a canalizzare le acque del fiume che spesso esondava trasformando in ampie paludi malsane quelle zone pianeggianti della valle. E come ben sappiamo, è nelle zone paludose che più facilmente si creano le condizioni per lo sviluppo della malaria (da mala aria) non a torto conosciuta anche come Morbus draconis, la malattia del dragone. Le cronache ci informano ancora che per tre giorni le acque del Nera fino al Tevere furono colorate di rosso dal sangue del drago (frutto del dilavamento di terra ricca di composti ferrosi) e che da questo periodo iniziò la rinascita (sotto il profilo agricolo) del territorio: la resurrezione del figlio della vedova. Spesso percorro il sentiero che unisce Sant’Anatolia di Narco a Vallo di Nera e che passa a lato della Chiesa, all’ombra di una vegetazione in parte autoctona punteggiata dalla presenza di numerosi Pini d’Aleppo che secondo tradizione sarebbero i discendenti di quei pini portati dalla colonia siriana più di millecinquecento anni fa.
RIFLESSO
Registrazione Tribunale di Perugia n.35 del 09/12/2011
ISSN 2611-044X



